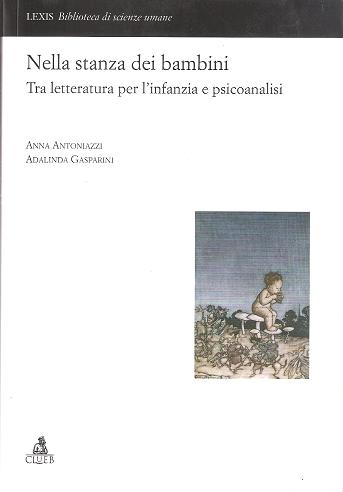| CLUEB | ANNA ANTONIAZZI E
ADALINDA GASPARINI NELLA STANZA DEI BAMBINI TRA LETTERATURA PER L'INFANZIA E PSICOANALISI |
BOLOGNA 2009 |
|
||
|
Capitolo QUARTO Guardare altrove Anna
Antoniazzi troppe cose terribili e stupende accadono
nella disubbidienza. L’infanzia
narrata dalle storie è portatrice di una
straordinaria peculiarità: è capace di osservare
il mondo da prospettive insospettate, di
oltrepassare soglie visibili solo ai suoi occhi,
di dilatare i confini della realtà a suo
piacimento, di sperimentare, utilizzando processi
conoscitivi insoliti e bizzarri, forme percettive
“altre”. Parafrasando Dieter Richter[1]
si potrebbe affermare che i personaggi infantili
della letteratura sono enigmatici frontalieri, non
solo perché “in terra straniera mutano il loro
aspetto come camaleonti[2]”,
ma soprattutto perché sono sempre pronti ad
attraversare i confini definiti dagli adulti,
varcando soglie che solo lo sguardo bambino può
cogliere come tali. L’infanzia
narrata, con la sua carica di spregiudicata
apolidità rispetto a regole e confini è, dunque,
in grado di sovvertire la polarità del mondo
percettivo adulto. Gli organi sensoriali di cui è
fornita si muovono nella realtà secondo coordinate
autonome che sfruttano come unico limite quello
della possibilità. Potenzialmente
nessuna eventualità è preclusa al bambino
protagonista delle storie e principalmente quella
di poter spostare la propria attenzione altrove,
scorgendo passaggi segreti e presenze misteriose
là dove gli adulti percepiscono unicamente
stabilità e coerenza al “reale”. Le tracce
lasciate da un’alterità non più riconoscibile per
chi abbia superato la soglia dell’infanzia,
allettano i bambini, li incuriosiscono e li
spingono a fornire personali interpretazioni. I
luoghi, anche quelli più vicini e intensamente
vissuti, sono concepiti come dimensioni fluide,
dinamiche, plastiche e diventano oggetto di un
continuo esercizio di riconversione, ribaltamento,
rinnovamento. Ogni elemento esterno ed interno al
bambino influisce sulla sua percezione generale
del mondo, e in primo luogo l’emotività. Felicità,
malinconia, tristezza, rabbia e altri stati
d’animo in ogni variante e modulazione
contribuiscono a fornire connotati diversi anche
alle mura domestiche e, dentro quelle, perfino
alla propria stanza. La
dimensione dell’avventura, così necessaria
all’infanzia – e non solo – per mettersi alla
prova, per saggiare i propri limiti, per
sperimentare le proprie potenzialità, diviene una
costante esistenziale, oltre che una priorità
fisiologica. Si tratta di un’avventura che,
inevitabilmente, preoccupa, spiazza e sconvolge
l’adulto perché, detentrice di un forte potenziale
trasgressivo, prevede che l’ordine stabilito sia
infranto e sia ricercato, in qualche modo, un
nuovo equilibrio: d’altra parte non si diventa
adulti senza sperimentare l’alterità e senza
assumersi la responsabilità diretta di tutti i
rischi che crescere comporta, anche quello di non
essere compresi e supportati. A
complicare il rapporto di reciproca incomprensione
tra infanzia ed età adulta sta la sconcertante e
particolarissima modalità di approcciarsi
all’esperienza da parte del bambino; modalità che
prevede una bizzarra forma di determinismo secondo
la quale è vero che ad ogni causa
corrisponde un effetto, ma lo è altrettanto che
quasi mai la causa di un fenomeno è quella
ritenuta più ovvia e banale. Lucy
girava per la casa. Era tutto tranquillo. Sua
madre stava versando la marmellata appena
fatta nei barattoli. Suo padre era al lavoro:
era un suonatore di tuba. Suo fratello era in
salotto a giocare ai videogiochi con il
computer. Lucy udì dei rumori. Erano rumori di
trambusto e animazione. Erano fruscii e
scricchiolii. Erano rumori furtivi,
striscianti, graffianti[3]. La madre, il padre e anche il
fratello adolescente percepiscono gli stessi
rumori, ma li attribuiscono ai topi: creature
scomode, disgustose, ributtanti, ma socialmente
riconosciute come possibili, anche se sgradite,
ospiti dei muri delle vecchie abitazioni. Lucy sapeva quali creature possono fare
quel genere di rumore nei muri di una vecchia,
grande casa, e andò a dirlo a sua madre. ‘Ci sono lupi nei muri’ disse alla
mamma. ‘Li sento.’ ‘No’ disse sua madre. ‘Non ci sono lupi
nei muri. Forse hai sentito i topi.’ ‘Lupi’
insistette Lucy. ‘Io sono sicura che non sono lupi’
disse sua madre. ‘Lo sai cosa si dice, no? Si
dice che se i lupi escono dai muri, è finita.’ ‘Cosa è finito?’ chiese Lucy. ‘TUTTO’
disse sua madre. ‘Chiunque lo sa.’ Lucy, che da giorni studia i rumori
e indaga le abitudini delle presenze che si
muovono all’interno delle pareti, sa bene quale
sia la verità, ma impara presto che se le porte
del possibile, quelle che consentono ai lupi di
uscire dai muri, venissero aperte, gli adulti – e
spesso anche i fratelli adolescenti – non
sarebbero in grado di reggere la situazione.
Impara anche che se i lupi, o altri improbabili
ospiti, uscissero dai muri, solo lei sarebbe in
grado di padroneggiare quella nuova realtà e di
ristabilire l’ordine infranto. Come Lucy sono tanti i piccoli
protagonisti delle storie che,
senza uscire dai confini della propria camera, o
della propria casa, ma rivolgendo ad essa uno
sguardo speciale, si trovano a vivere avventure
straordinarie dalle quali tornano, quasi sempre,
più forti e consapevoli. L’esperienza
dell’alterità, infatti, benché sconvolgente e
inquietante, permette all’infanzia non solo di
attivare efficaci meccanismi di difesa, ma di
confrontarsi, attraverso un processo di
straniamento dalla realtà, con gli aspetti del
sé più nascosti e indicibili. Aggressività, rabbia, ira sono
pulsioni forti e improvvise con le quali il
bambino deve imparare a fare i conti. Ma, come
fare senza esplorarle, senza capire come
funzionano, senza sapere dove conducono? La
tentazione adulta ricorrente, nella finzione delle
storie e nella realtà, è quella di sedarle, di
reprimerle, di annullarle, magari attraverso
punizioni o ricatti, ma le strade percorribili più
efficaci sono altre. Grande conoscitore del potenziale
immaginativo e intuitivo dell’infanzia, Maurice
Sendak fornisce una via d’uscita straordinaria
dall’empasse, anche educativo, suscitato dal
manifestarsi dirompente dell’aggressività. Quella sera Max si mise il costume da
lupo e ne combinò di tutti i colori e anche
peggio. La mamma gli gridò: ‘MOSTRO SELVAGGIO’
e Max le rispose: ‘E IO TI SBRANO’. Così fu
mandato a letto senza cena[4].
Fin qui, apparentemente, non accade
nulla di strano: Max, il piccolo e terribile
protagonista, dopo aver dato libero sfogo alle
proprie pulsioni negative, viene punito dalla
madre nel più classico dei modi. In realtà Sendak
fin dalle prime battute e dalle prime immagini
fornisce un indizio particolare sulla sua
interpretazione della storia: il bambino ha
indossato la maschera da lupo, ovvero, nel momento
della manifestazione dell’aggressività è uscito
dal sé conosciuto per diventare l’incarnazione –
secondo una simbologia ricorrente – della
negatività: il lupo. Il bambino Max ha ceduto il
posto al lupo Max che agisce di conseguenza.
Questo processo di presa di distanza da sé,
attraverso la maschera, è necessario a Max per
sperimentare l’alterità e, infine, ritrovare se
stesso. Sendak, da genio qual è, esaspera
la situazione particolare della quale il
bambino-lupo si trova a fare esperienza e,
assecondando lo sguardo di Max, frase dopo frase,
inquadratura dopo inquadratura, trasforma le
pareti della stanza in una foresta intricata, poi
in un mare sterminato e, infine, come palesa il
titolo dell’opera, nel paese dei mostri selvaggi.
E appena arrivato nel paese dove
abitano i mostri selvaggi quelli ruggirono
terribilmente digrignarono terribilmente i
denti rotearono tremendamente gli occhi e
mostrarono gli artigli orrendi fino a che Max
gridò: ‘A CUCCIA!’ e li domò con il trucco
magico di fissarli negli occhi gialli senza
batter ciglio. Nel paese dei mostri selvaggi,
naturalmente, vive una moltitudine di esseri
dall’aspetto e dai modi terrificanti ognuno dei
quali ha specificità e caratteristiche sue
proprie, che lo rendono identificabile e
coralmente riconoscibile. Ogni mostro sembra
incarnare una singola, particolare pulsione
negativa di Max: uno l’aggressività, un altro la
rabbia, un altro ancora il desiderio di
prevaricazione, la prepotenza, e così via. Il protagonista della storia, da
parte sua, non si limita a riconoscere i mostri, a
distinguerli nell’aspetto, ad individuarne le
particolarità: li controlla ritualizzandone i
gesti, prima incontrollati e incontrollabili,
attraverso una ridda – scatenata, selvaggia e al
tempo stesso liberatoria – al chiaro di luna. Solo
dopo aver compiuto questo passaggio, chiarissimo
dal punto di vista metaforico e simbolico, Max può
percorrere il cammino inverso e riappropriarsi
della propria identità bambina; solo dopo aver
rimesso, con autorevolezza, ordine al caos che
regnava dentro e fuori di sé, può riavvolgere il
filo del tempo e tornare a casa pacificato dentro
e fuori, dal momento che anche la mamma è tornata
sui suoi passi e gli ha lasciato la cena “che era
ancora calda”. Attraverso Max e le creature
selvagge che scaturiscono dalla sua emotività
Sendak racconta, senza censure e senza inibizioni,
la potenza creativa e autopoietica dell’infanzia,
il suo essere in grado di generare mostri e allo
stesso tempo di ammansirli, utilizzando
l’autorità, mai la forza. Inevitabilmente, però,
quando i protagonisti delle storie si allontanano
dalla prima infanzia e cominciano ad approssimarsi
all’adolescenza, altre inquietudini, altri mostri
ed altri fantasmi si affacciano all’orizzonte
emozionale, in primo luogo quelli che prevedono il
progressivo e inevitabile distacco dalla famiglia,
e in particolare dai genitori. Genitori che
cominciano ad essere considerati un ostacolo
insormontabile alla propria autonomia. Se Maurice
Sendak, aprendo i confini della stanza di Max, ha
metaforicamente aperto i confini della sua
dimensione esperienziale, dichiaratamente
infantile, mettendo in scena un modo particolare
di affrontare la propria parte oscura, spetta a
Neil Gaiman e Dave McKean, attraverso un
personaggio come Helena, protagonista del film MirrorMask[5]
e della omonima grafic novel[6],
approfondire il tema esplorando il periodo di vita
successivo a quello infantile. Helena si
trova sulla soglia di quell’età che non si teme di
definire “critica”, nella quale ogni rapporto,
ogni emozione, ogni circostanza assume un
carattere mobile, precario, problematico. Un’età
nella quale prendere le distanze dagli altri
significa, in primo luogo, prendere le distanze da
un sé che non si è più in grado di riconoscere né,
tantomeno, di gestire. Un’età nella quale ogni
evento assume connotati parossistici, in
particolare quando l’ordine degli eventi si
scontra con gli strascichi della propria infantile
illusione d’onnipotenza: quella di essere causa
unica e determinante di tutto ciò che accade. Quella sera mamma era letteralmente
furiosa, ed era tutta colpa mia. Avevo come perso la cognizione del
tempo, ed ero nella mia roulotte a inventare
una storia con i miei calzini, quando Mamma ha
iniziato a battere sul finestrino ed era tutto
un ‘Helena, non sei nemmeno vestita ancora’ (e
invece lo ero), e io ero tutto un ‘Mamma, non
ne posso più. È sempre la stessa storia:
Helena sorridi agli spettatori, Helena vendi i
popocorn, Helena fai il giocoliere, Helena dai
una mano a lavare i piatti’ e lavare i piatti,
persino in un circo piccolo come il nostro è –
be’, non ci credereste cos’è, ecco. ‘Senti quei bambini laggiù’ ha detto la
Mamma. ‘Vogliono tutti scappare via e unirsi
al circo’. ‘Buon per loro’ ho replicato. ‘Io
invece voglio scappare via e unirmi alla Vita
vera’. Dopo di che la discussione è andata
solo peggiorando, io dentro la roulotte e lei
fuori, io che le dicevo che mi stavo vestendo
e che non gridasse e lei che gridava che non
stava gridando, e tutto era diventato già
abbastanza orribile quando lei ha detto: ‘Mi
farai morire’ e io ho risposto: ‘Magari’. Non pensavo di averlo detto abbastanza
forte da farmi sentire, ma lei è ammutolita.
Era come se quella parola fosse rimasta
sospesa lì nell’aria e non potesse più essere
non detta. Il senso di
colpa comincia a lavorare fino ad esplodere nel
momento in cui, pochi minuti dopo la discussione,
la madre di Helena viene ricoverata in fin di vita
in ospedale. Incapace di elaborare la situazione,
attanagliata dal rimorso, la ragazzina si convince
di essere l’unica e assoluta responsabile del
dramma: le sue parole hanno sortito un effetto
devastante e per colpa sua la madre è destinata
alla morte. La
necessità più impellente è, ora, quella di
comprendere ciò che è accaduto, di rimettere
ordine nei propri sentimenti, di controllare le
proprie pulsioni distruttive, ma per farlo deve
prendere le distanze da sé, ritrovare un nuovo
baricentro esistenziale, rompere i confini delle
emozioni conosciute per esplorare l’alterità
oscura che si annida dentro di sé. Paralizzata dal
dolore, Helena si isola dal mondo, si estrania da
una realtà che percepisce sempre più disorganica,
incontrollabile, pericolosamente fallace; ma
l’isolamento – proprio come è accaduto nella
storia narrata da Sendak – lungi dal portare a un
ripiegamento autistico, a una chiusura percettiva,
spalanca le porte del possibile e si attesta come
produttore di senso. Senza esserne pienamente
consapevole, e senza mai lasciare fisicamente la
stanza nella quale si è rifugiata, Helena si
accinge a compiere un viaggio nel mistero che
avvolge l’ambigua duplicità delle esperienze, dei
sentimenti, dei rapporti, oltrepassando
continuamente il sottile confine che dovrebbe
separare, ma spesso confonde, amore e
prevaricazione, dedizione e indifferenza, lealtà e
tradimento, tenerezza e rigore. Un viaggio
metaforico che la condurrà in un mondo altro dal
quale, attraverso specchi, finestre, quadri,
strane aperture trasparenti, può osservare
un’altra se stessa – capricciosa, insolente,
malvagia – vivere, in maniera distorta, la sua
stessa esistenza. Quella di
Helena è un’avventura intima, vissuta
dall’interno, è un’iniziazione personalissima, un
percorso assolutamente originale alla scoperta del
proprio sé nascosto, inquietante ed oscuro;
un’avventura in uno strano mondo parallelo ricco
di creature fantastiche, di esseri mitologici, di
situazioni fiabesche che comincia,
non a caso, di notte, durante un sogno. Nel mio sogno il mio riflesso rideva di
me. Nel mio sogno ero due ragazze diverse. Nel
mio sogno Mamma stava per essere operata, e
quando ha aperto gli occhi erano neri come uno
specchio nero… In quel
momento accade qualcosa di particolare, un antico
equilibrio comincia a vacillare ed Helena, una
volta sveglia, osserva la sua stanza con occhi
nuovi, stupiti, avidi e non esita a seguire
Valentine: un misterioso ragazzo dal volto coperto
da una maschera. Insieme a lui oltrepassa una
porta segreta e accede ad una realtà nuova dove
ogni regola è stravolta e ogni incontro possibile,
perfino quello con un’altra Helena: una Helena
malvagia, crudele, perfida, oscura. Un
movimento che proveniva dalla finestra
nell’angolo ha attirato la mia attenzione,
sono andata lì, l’ho pulita e ho visto… Me. Solo che non ero io. Lei non indossava il tipo di vestiti
che io indosserei. E urlava contro il mio
papà. Lui sembrava spaventato, e stanco. Non
sopportavo che lei stesse gridando e che lui
non le dicesse niente, che stesse addirittura
indietreggiando di fronte a lei. Ho battuto rabbiosamente contro il
vetro. La ragazza che non ero io si è girata e
per un attimo, sono sicura, ha guardato
proprio me. La finestra
alla quale Helena si affaccia non solo mette in
comunicazione i due mondi dei quali è partecipe,
ma la pone in condizione di osservare se stessa
dall’esterno, nell’atto di compiere azioni che
difficilmente avrebbe imputato a se stessa, o
quanto meno alla “vera” se stessa. Nel
confronto con il proprio doppio, con la propria
alterità oscura e grazie al superamento delle
prove affrontate nell’altrove magico e perturbante
nel quale Valentine l’ha condotta, Helena dimostra
di essere cresciuta e acquisisce il diritto,
legittimo, alla propria autonomia. Ma prima che la
sua iniziazione alla vita possa considerarsi
conclusa occorre superare un ultimo ostacolo:
trovare MirrorMask, la MascheraSpecchio, l’unico
oggetto in grado di catalizzare il ritorno della
ragazzina alla propria vita. Ritorno che,
inevitabilmente, coincide con l’esilio
dell’altra-Helena. È stato in quel momento che ha visto la
finestra che io avevo disegnato a carboncino
sul retro della porta. C’ero anch’io, nella finestra, e la
stavo guardando. Avevo in mano la
MascheraSpecchio. È rimasta di stucco. “Non tornerò là!” ha detto. “Non puoi
costringermi.” Le parole sono sue, ma la voce
era mia. “Sto bene qui.” “È il mio mondo” ho replicato. “La mia
vita. Non puoi prendertela.” Il vento soffiava, là, sul tetto, e lei
sembrava molto piccola e molto sola. Non penso
che la vita ci prepari a molto eccetto, a un
certo punto, l’andarcene di casa. Lei ha
detto: “Volevo semplicemente una vita vera.” “Una vita vera?” le ho detto io. “Non
sapresti cavartela nella vita vera.” E mi sono infilata la MascheraSpecchio. “Non sapresti
cavartela nella vita vera”: con questa frase, la stessa
pronunciata dalla madre durante il litigio, il
cerchio della vecchia esistenza di Helena si
chiude per aprirsi a nuove, inedite possibilità.
Ora che la ragazzina ha dimostrato la propria
autonomia, anche la mamma può riprendere il
proprio posto e, simbolicamente, proprio come
accade nelle fiabe, ri-svegliarsi dal proprio
sonno mortale. La
MascheraSpecchio, dunque, non solo diviene
metafora della crescita di Helena, ma anche, e
soprattutto, del cambiamento che si manifesta in
lei nel momento in cui viene reciso, per la
seconda volta, il cordone ombelicale: quello che
la unisce alla sua famiglia. Come ammette la
stessa protagonista, infatti, «è un po’ come
essere un dio, credo, indossare la
MascheraSpecchio. O è un po’ come scrivere un
libro. Puoi aggiustare le cose, o puoi fare
capitare eventi nella tua testa e lasciare che si
aggiustino da soli. Non è difficile». Come non è
difficile, dopo avere scoperto che si può
sopravvivere – come figlia e come madre – alla
separazione e che l’autonomia personale è
realizzabile, ritornare sui propri passi e
riprendere in mano i fili della propria vita. Il
ritorno a casa di Helena diviene così il momento
cruciale in cui alla crisi dei valori segue una
nuova fondazione della propria identità;
un’identità che non cesserà mai di definirsi,
complicarsi, approfondirsi, ma con la quale –
attraverso il riconoscimento della propria
duplicità oscura – la ragazzina ha imparato a
misurarsi. Cedo alla
tentazione di concludere utilizzando la pagina del
diario di Helena con la quale termina MirrorMask e
che rappresenta una sorta di manifesto per quanti
si accingono, speranzosi, a lasciare i panni – confortevoli ma al
tempo stesso viscosi, scomodi e fastidiosi –
dell’infanzia, ma senza volerne abbandonare il
sogno. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi da
allora, ma è quello che hanno tutte le
famiglie. Papà ha riportato il circo in strada
e Mamma si è unita a noi ad Aberdeen. Non fa l’esercizio alla fune né il
Gorilla, però. E papà ha detto che è d’accordo che io
mi iscriva a una scuola d’arte tra qualche
anno. Prima o poi avrà bisogno di un nuovo
giocoliere. Ricordo ancora quella notte, e quel
sogno. Talvolta, quando vedo dei gatti, mi aspetto che abbiano volti umani e
denti aguzzi e piccole ali. E appoggio sempre i miei libri con
attenzione, nel caso dovessero volare via o
spiccare un salto in aria per tornare da soli
al loro scaffale. C’è una sola cosa che mi manca nella
vita in questo momento, e sono quasi sicura
che è là fuori, da qualche parte. Voglio dire, c’era una me nell’altro
mondo e c’è una
me anche qui. Perciò sono piuttosto sicura che lo
troverò, se tengo gli occhi aperti. E c’è una cosa che so di lui (di Valentine). Non so come si chiami in questo mondo, e non so per la verità nemmeno che
aspetto abbia con una faccia vera. Ma se tengo gli occhi aperti, so che un
giorno m’imbatterò in lui. Dopo tutto, non vuole mica davvero
fare il cameriere. [1]
Dieter Richter, Pinocchio o il
romanzo d’infanzia, Edizioni di storia e
letteratura, Roma, 2002. [2]
Ivi, p. 6. [3]
N. Gaiman, D. McKean, Lupi nei muri,
Milano, Mondadori, 2003. [4]
M. Sendak, Nel paese dei mostri
selvaggi, Milano, Babalibri, 1999. [5]
D. McKean, MirrorMask,
GB, 2005. [6]
N. Gaiman, D. McKean, MirrorMask. La MascheraSpecchio,
Milano, Mondadori, 2006. |
||
Capitolo QUARTO
Adalinda
Gasparini Nelle versioni più antiche delle Mille e una notte, risalenti a manoscritti del XIV secolo, si racconta di un misero pescatore, che dopo una giornata in cui non aveva pescato nemmeno un pesce lanciò la rete per l’ultima volta, e pescò un boccale di rame[1]. Pensando di venderlo al mercato per ricavarne almeno la cena per sé e per la sua famiglia, volle pulirlo e ne rimosse il sigillo. Dall'apertura si sprigionò un fumo denso che salì verso l'alto, e subito si condensò in un immane jinn che gli disse di prepararsi a morire. La terrificante figura gli raccontò di essere uno dei geni ribelli che Salomone aveva imprigionato in vasi di rame sigillandoli col suo anello. Il grande re portava al dito un sigillo che, avendo impresso il nome segreto di Dio, gli dava autorità su tutti i demoni, o geni, della terra dell'aria e delle acque. Jinn significa demone, e la sua traslitterazione europea, génie, genio, lo lega al latino genius. Le parole suggeriscono una parentela fra lo spirito personale, che indica la particolarità soggettiva e irriducibile di ogni essere, e il demone delle favole arabe: torneremo più avanti sulla potenza della parola che le favole custodiscono. Quando il genio disse al pescatore che come premio per la sua liberazione lo avrebbe ucciso, il misero pescatore lo supplicò inutilmente, e il genio acconsentì a raccontargli la ragione della sua crudeltà. Nei primi secoli che aveva passato in fondo al mare aveva pensato di ricompensare il suo liberatore rendendolo immensamente ricco, ma nessuno era venuto. Nei secoli seguenti aveva quindi stabilito che gli avrebbe mostrato i tesori sepolti nella terra, ma nessuno era venuto. Nei successivi cento anni aveva giurato che avrebbe fatto diventare re il suo liberatore, sarebbe stato il suo schiavo e ogni giorno avrebbe soddisfatto tre suoi desideri: anche questa volta la sua attesa fu vana. A quel punto aveva stabilito di uccidere chiunque lo avesse liberato. Sentendo questa storia il pescatore supplicò il genio recitando versi che mostravano il valore della clemenza, ma tutto fu inutile. Finalmente pensò che usando la ragione di cui Dio lo aveva dotato come essere umano sarebbe riuscito a giocare il demone. Un essere piccolo e debole rischia di essere annientato da un essere potentissimo. Prima di riconoscere nella letteratura fiabesca altri esempi di questo confronto, il cui valore non è mai abbastanza sottolineato, cerchiamo di comprendere la motivazione apparentemente assurda con la quale il genio spiega la sua condanna del liberatore. Quando la mamma lascia solo il suo bambino piccolo, il bambino immagina dapprima di renderla felice al suo ritorno, come se il suo desiderio e la sua dedizione potessero farla tornare. Come il genio prigioniero in fondo al mare il bambino incrementa con al fantasia il suo dono, ma la mamma non torna per riceverlo, e a un certo punto, frustrato nella sua attesa reagisce con collera al senso di impotenza che lo minaccia: ribalta il dono nel suo opposto, e al ritorno della mamma resta in silenzio senza guardarla, come se fosse indifferente o si nasconde come se non volesse vederla. L'onnipotenza del suo desiderio di lei si è capovolta nel desiderio di annientarla, come quella del demone verso il liberatore. Di solito il bambino esce dal suo nascondiglio e torna ad abbracciare la mamma, ma un allontanamento prolungato e vissuto drammaticamente può trasformarsi in una ferita narcisistica insopportabile e provocare una reazione di tipo autistico. Una frustrazione del desiderio percepita come intollerabile può trasformare la tenerezza illimitata in un odio altrettanto intenso. Del resto anche gli adulti possono sperimentare facilmente come un innamoramento totale si capovolga facilmente in odio, anche se è destinato a diventare indifferenza e distacco. Nella storia che andiamo a vedere, L'enfant et les sortilèges (Colette, 1916), potremo riconoscere l'angoscia della solitudine che subentra all'aggressione contro la persona amata che non ci ha accontentato, dalla quale dipende la nostra vita. Il misero pescatore di fronte al genio il cui capo sfiora le nuvole, come il Gatto con gli stivali di fronte al potente orco, immaginano una scena impossibile per il loro avversario, che, sicuro della sua superiorità, cade nel tranello. “Tu che ti sei trasformato in leone”, chiede il Gatto all’orco, “sapresti anche diventare piccolo come un topolino?". “Prima di uccidermi,” chiede il pescatore al genio, “puoi spiegarmi come facevi a stare in questo vaso, tu che sfiori col capo le nuvole?” L’inferiore, già in balia del gigante, chiede: “Tu che sei così grande, non sai diventare piccolo, più piccolo di me?” L'essere sovrumano ride e sempre pronto a esibire la sua potenza si trasforma in un topolino che il gatto divora in un batter d'occhio, o rientra nel boccale condensando la sua sostanza di fumo, così che il pescatore chiude lesto il boccale col sigillo di Salomone e lo riduce in suo potere. Il genio appena uscito dalla sua prigione conosce i segreti tesori della terra e può uccidere o far diventare re l'uomo che incontra. È ribelle, non riconosce l'autorità di Salomone, e preferisce essere imprigionato anziché sottomettersi. Il pescatore consapevole della sua debolezza si posiziona sullo stesso asse dal quale proviene il sigillo magico del grande Salomone, il nome di Dio, che lo ha dotato di ragione, di parola. La reversibilità del fantasma, dell'apparizione, non è forse l'esperienza che ci permette di tornare alla luce, alla coscienza, dopo un incubo? La forma minacciosa che si è presentata, la magia alla quale ha risposto, la formula o l'astuzia, non possono farla tornare al suo posto, permettendo di tornare alla propria vita, insieme agli altri? Siccome il suo appello alla clemenza era stato inutile, quando il pescatore ebbe di nuovo in mano il vaso sigillato, gridò al demone che l’avrebbe rigettato in fondo mare, dove avrebbe passato altri millenni a meditare sulla sua crudeltà. Fu allora la volta del genio di supplicare, e a questo punto cominciarono a raccontarsi storie, quelle del pescatore dicevano di persone che essendo state generose erano state ripagate con crudeltà, quelle del genio raccontavano come chi era stato generoso avesse ricevuto un bene immenso. Le favole possono essere usate per illustrare verità opposte, come i proverbi, come il linguaggio. La soluzione è nella possibilità di un accordo, e così il pescatore alla fine fece un patto col genio, che liberò solo dopo che ebbe giurato di rispettarlo sul divino sigillo di Salomone. Lui ricevette un dono che rese ricchissimo lui e tutta la sua famiglia, e da questa storia derivò la liberazione di una città pietrificata. Nel Paese del mostri illustrato da Maurice Sendak (1963) il bambino che non vuole smettere di fare il lupo, fuggito dalla sua stanza per ribellarsi alla punizione materna, incontra esseri che ricordano gli orchi e i draghi delle favole antiche, ma anche gli adulti dai quali il bambino si sente minacciato, come se potessero distruggerlo. Il piccolo di Sendak è solo, in tutta la sua storia l'adulto è fuori campo, disarmato come il pescatore di fronte al demone, come lui ricorda la sua natura umana e ne fa uso per domare le creature selvagge, con lo sguardo e l’ordine: “A cuccia!” La superiorità dell'essere umano poggia sulla sua fiducia nel suo strumento specifico, la parola, che nelle fiabe è formula che salva, aprendo porte che nessuna arma può scalfire, riducendo in suo potere mostri che potrebbero divorarlo o incenerirlo. Una volta domate le creature immaginarie, una volta scoperta la propria ricchezza di essere umano, il bambino torna a casa, dove ritrova ancora calda la sua cena. Nella fantasia si mette in scena e si addomestica qualcosa che affiorando esige di essere visto e ascoltato, come il pericoloso e vitale desiderio di ribellarsi a qualunque costo. L'enfant et les sortilèges: un bambino non vuole fare i suoi compiti, non obbedisce, e risponde con sgarbo alla mamma che lo rimprovera. Riceve quindi per merenda solo tè senza zucchero e pane secco, e dovrà restare solo nella sua stanza fino all'ora di cena. Così racconta la storia di Colette, musicata da Ravel: il balletto L'enfant et les sortilèges fu rappresentato per la prima volta a Montecarlo nel 1925[2]. Come nella storia di Sendak, la punizione è percepita come una frustrazione intollerabile, e la ribellione esprime il tentativo di cancellarla. Nella collera onnipotente e impotente il bambino non è più il piccolo, diventa come il demone delle Mille e una notte. Non vuole sottomettersi all'ordine della parola, alla madre che gli impone di fare i suoi compiti e di non mancarle di rispetto. Il suo genio ribelle esce dai confini del suo stesso corpo e anima la stanza di presenze inquietanti. L'ordine divino delle Mille e una notte si riproduce attraverso il nome segreto sull'anello del sovrano, parola assoluta e impronunciabile dalla quale sembra originarsi l'ordine stesso del linguaggio. Se il bambino non si inserisce in questo ordine gli oggetti della sua stanza, del mondo che è dentro di lui, della prigione in cui viene confinato, si ribellano. Respingendo la madre, come se potesse ottenere una libertà senza confini, si troverà in un mondo sconfinato dove ogni figura inanimata può prendere vita e perseguitarlo. Melanie Klein vide un sintesi del racconto di Colette in una presentazione berlinese del balletto di Ravel, e nel 1929 scrisse il saggio Situazioni d'angoscia infantile espresse in un'opera musicale e nel racconto di un impeto creativo. Nel breve testo possiamo riconoscere l'anticipazione di concetti kleiniani che possono essere considerati fra i maggiori contributi nella storia della psicoanalisi dopo Freud, sia teorici che clinici [3].
A quale condizione il bambino risponde positivamente alla regola che l'adulto gli impone? come può scegliere di entrare nell'ordine del linguaggio rinunciando alla sua onnipotenza che lo spingerebbe in un mondo tutto suo, separato da quello comune a tutti? Non si può descrivere il confine fra ordine collettivo e libertà soggettiva, ma si può parlare dell’espressione artistica, che abita su questo confine, e può essere concepita come viva e mobile traccia, nella quale il soggetto può muoversi per trovare il proprio percorso. La parola soggetto contiene due valenze contrapposte: il soggetto è tale in quanto assoggettato a un ordine, ed è soggetto di una frase, attante soggetto di una storia, protagonista della propria vita. L'educazione trasmette la necessità dell'assoggettamento: il soggetto-bambino nell'opera di Colette e Ravel, come in quella di Sendak, rifiuta di assoggettarsi. La prigione in cui si trova confinato diventa lo spazio in cui esprime la propria ribellione, ma il suo rigetto dell'ordine materno diventa la perdita dell'organizzazione di sé e degli oggetti nello spazio, come in un incubo notturno. È esperienza comune svegliandosi dopo un sogno d'angoscia restare inconsapevoli della realtà fisica della propria stanza, immobili, non sapendo più i confini del nostro corpo, la disposizione del letto: a volte non è possibile nemmeno accendere la luce: per un tempo senza tempo esitiamo nel buio, perché non sappiamo la luce mostrerà i mobili e le pareti che conosciamo bene o le figure terrifiche dell'incubo appena passato. La comune breve esperienza di terrore, simile al delirio, ci guida alla comprensione dei mostri che abitano questo racconto, nel quale sparisce il confine tra il possibile e l'impossibile: ciò che è inanimato si anima, creature senza parola cominciano a parlare, le fiamme escono dal focolare e sembrano sul punto di bruciare il bambino, le figure della tappezzeria decorata con scene pastorali strappata dal soggetto in collera danzano nella stanza lamentando la pace perduta: – Il
bambino cattivo ha sconvolto La
nostra tenera storia, Pastore
di
qua, pastorella di là, Il
bambino cattivo che ci deve Il
suo primo sorriso. (Colette, L'enfant et les sortilèges) La teiera e la tazza prendono vita e danzano fra loro, mentre la matematica, istanza d'ordine e di regole certe, entra in scena, con la forma di un ometto che pone problemi e operazioni il cui risultato bizzarro sconcerta: Il
Bambino (confuso): – Quattro e quattro? Il
vecchietto (suggerendo): – Diciotto! Il
Bambino: – Undici e sei? Il
vecchietto: – Venticinque! Il
Bambino (esagerando decisamente): – Tre per nove
quattrocento! (Ibidem) Poi arriva il gatto di casa, enorme rispetto al bambino, vuol giocare con la sua testa come se fosse una pallina, e poi va verso il giardino. Il bambino lo segue, lasciando la sua stanza dove niente più lo accoglie, nemmeno la poltrona che lamenta le sue pedate: nel giardino spera di trovare sollievo, ma anche le creature che abitano il parco, simile al bosco di Sendak, sono contro di lui, rimproverandogli il male che ha fatto loro[4]. L'albero, sanguinando linfa, lamenta le ferite che gli ha inferto col coltello, e altri alberi gli fanno coro, la libellula piange la perdita della sua compagna, che il bambino ha trafitto con uno spillo, il pipistrello gli ricorda che ha ucciso un suo simile col bastone. Il bambino è schiacciato dalle conseguenze del suo sadismo, del suo desiderio sadico rivolto contro gli esseri senza parola. Il pipistrello, la creatura notturna che ha ucciso, aveva dei piccoli, che ora rischiano di morire perché nessuno li nutre. Lo scoiattolo lamenta di essere stato chiuso in gabbia, in prigione come il bambino stesso confinato nella sua stanza, e il bambino cerca di difendersi: Il
Bambino (allo scoiattolo): – La
gabbia, era per vedere meglio la tua sveltezza, Le
tue quattro piccole mani, i tuoi begli occhi... Lo
scoiattolo (sarcastico): – Sì,
era per i miei begli occhi! Vuoi
sapere, cosa riflettevano i miei begli occhi? Il
cielo libero, il vento libero, i miei fratelli
liberi, Che
saltano come se volassero... Guarda bene Quello
che
riflettevano i miei begli occhi luccicanti di
lacrime! (Ibidem) Il giardino si riempie di scoiattoli che saltano e giocano fra i rami, sotto le raganelle giocano nell'acqua e le libellule in volo si sfiorano e si allontanano. A questo punto nel giardino, nel bosco, che rappresenta la natura materna, le creature danzano incontrandosi liberamente (Un
gruppo di sfingi dell’oleandro imita le
raganelle. Altri gruppi si formano e si disfano.
Il giardino, palpitante di ali e rutilante di
scoiattoli, è un paradiso di gioia e di
tenerezze tra gli animali.) Il
Bambino: –
Si amano.
Sono felici. Mi dimenticano... (Il
gatto nero e la gatta bianca appaiono in cima ad
un muro. Il gatto lecca amichevolmente le
orecchie della gatta e gioca con lei; si
allontanano camminando l’uno dietro l’altro
sullo stretto bordo del muro.) Si
amano... Mi dimenticano... (Inquieto,
quasi
senza voce) Sono
solo... (Ibidem) La gioia di questa scena dalla quale il bambino è escluso è come l'unione dei genitori che hanno il potere di dare vita, un potere che sfugge al suo dominio. La collera del bambino che lacera la tappezzeria, rovescia la sua colazione, si ribella alla madre, è l’aggressione contro la ricchezza dei genitori che il figlio ancora non può possedere, dalla quale si sente quindi minacciato. Ma la stessa aggressione si rivolge contro lui stesso, perché se distruggesse i genitori che non lo accontentano come vorrebbe resterebbe privo del loro aiuto, dell'amore col quale si dedicano a lui. Non soltanto: aggredendo l’unione dei genitori distruggerebbe ciò che ha dato origine alla sua stessa vita. Sono solo, dice il bambino a questo punto, e pur non volendo pronuncia la parola magica, mamma. Ma la pronuncia senza volerlo, perché il suo desiderio di ribellarsi è ancora forte, e ancora le figure nate dalla sua ribellione lo perseguitano accusandolo tutte insieme, impegnandosi a lacerarlo con i loro artigli, i denti, le unghie. Ciascuna vorrebbe castigarlo, e nella confusione finiscono con l’azzuffarsi fra loro, mentre il bambino sta in un angolo della scena. Quando uno scoiattolino viene colpito e lanciato accanto al lui, togliendosi un nastro dal collo gli fascia la zampina ferita. Gli animali se ne accorgono e mutano il loro atteggiamento: Gli
animali: –
Ha curato la
sua ferita... (tra
di loro) Soffre... È
ferito... Sanguina... Ha
curato la sua ferita... Bisogna
legare
la sua mano... Arrestare
il
sangue... Cosa
fare? Lui sa guarire il male... Cosa
fare? L’abbiamo ferito... Cosa
fare? (Ibidem) Lui sa guarire il male: il gesto del bambino è impossibile per gli animali, rappresenta la capacità umana che con compassione protegge la vita. Cosa possiamo fare, si chiedono gli animali, e quando uno di loro ricorda la parola pronunciata dal bambino, la ripetono insieme. Gli animali che avevano animato la scena dopo la fuga del bambino ripetono la parola che aveva pronunciato senza volerlo, in coro: mamma! Il bambino resta ancora inerte, tanto che gli animali temono che stia per morire, e decidono di portarlo alla sua casa, il solo posto dove possono curarlo. Lo sollevano insieme e continuano a dire la parola magica, sempre più forte; il bambino finalmente apre gli occhi e, sostenuto dagli animali, si alza in piedi, finché una luce si accende nella casa: Gli
animali: –
È buono, il
bambino, È
bravo... molto bravo... È
buono e bravo... È
così dolce. Il
Bambino (tendendo le braccia) : – Mamma! (Ibidem)
Klein nel saggio del 1929 coglie nell'opera la pregnanza del dramma che ogni bambino conosce, affrontando il quale articola il suo desiderio nell'ordine della casa, del linguaggio comune a tutti. La profonda intuizione psicologica dell’autrice del libretto, Colette, traspare nel modo in cui avviene la trasformazione dell’atteggiamento del bambino: quando egli soccorre lo scoiattolo ferito egli sussurra: “Mamma!”, e gli animali che lo circondano ripetono la parola. E’ da questa parola di redenzione che l'opera prende il titolo Das Zauberwort. (Klein, Situazioni d’angoscia…, p. 244) La messa in scena berlinese a cui si riferisce Klein si intitolava La parola magica. La parola più facile e più difficile del mondo, mamma, prima è sussurrata senza volerlo, poi detta e gridata da tutti gli animali, che desiderano che il bambino sia curato come lui ha curato la zampina dello scoiattolo, e dispiega la sua potenza pacificante quando il soggetto riunisce il suo mondo interiore nella speranza di essere perdonato, di tornare fra le braccia della madre che aveva aggredito. Allora è lui a chiamare volendolo, e la storia, e il balletto, finiscono. In una recente scenografia del balletto, quando il bambino si trova nel giardino entra in scena una gabbia a cupola, nella quale si trova con lo scoiattolo. Nell'ultima scena gli animali, dopo aver chiamato mamma in coro, rivestono la forma metallica con la veste della madre cha abbiamo visto all’inizio del balletto, sulla sommità si eleva la parte superiore del corpo appare e loro scompaiono come se entrassero nella gabbia-corpo-materno. A questo punto il bambino, chiamando a sua volta la madre, si arrampica su lei cercandone l'abbraccio. Questa scenografia sembra dare forma alla teoria kleiniana per la quale il bambino col suo sadismo aggredisce i tesori contenuti nel corpo materno, i suoi frutti, e la sua stessa aggressione si ribalta persecutoriamente contro di lui. La solitudine che sperimenta quando tutto ciò che lo circonda, prima nella sua stanza, poi nel giardino, gli è ostile, rimproverandogli la sua crudeltà e aggredendolo, sarà chiamata successivamente da Melanie Klein posizione depressiva. Riconoscendo che la sua ribellione non gli porta la soddisfazione del suo desiderio onnipotente, ma una condizione di prigionia e solitudine intollerabile, analoga a quella del genio delle Mille e una notte che non avendo avuto compassione per il povero pescatore si ritrova chiuso nel vaso di rame, il bambino aveva perso i sensi, giaceva in un angolo della scena, come se stesse per morire. Le figure della sua immaginazione allora lo soccorrono, portandolo verso lo spazio in cui potrà chiedere e ricevere aiuto. Il bambino deve rinunciare all'espressione della sua aggressività illimitata, alla sua fuga dalla madre, dalla casa, perché il bosco gli fa sperimentare l'ostilità che lo preme da ogni parte. Ne esce solo pronunciando, sostenuto dal coro delle figure della sua fantasia, la parola magica, spesso la prima con la quale il bambino partecipa attivamente al linguaggio. La parola mamma nasce e resta al confine fra il balbettio e la parola, e ogni volta che la pronunciamo ritroviamo questo confine, lo stesso che attraversiamo quotidianamente addormentandoci e risvegliandoci, fra i sogni notturni e la veglia. In questo passaggio il racconto è mappa preziosa, perché sospende la regola senza dimenticarla, e lascia libere le figure della fantasia mantenendo la facoltà di farle rientrare nel cerchio della narrazione. È come se, sentendo la storia, il bambino sapesse che altri hanno desiderato come lui di disobbedire, o anche di eliminare la madre, come fece Cenerentola nella sua versione secentesca (Basile). Qualcuno come lui si è trovato privo della sua protezione, come tutte le Cenerentole del mondo, orfane della buona madre e in balìa della cattiva matrigna. Qualcuno come me, il bambino lo sa ascoltando una favola, ha perduto il conforto della casa, e pur sentendosi colpevole, al punto di diventare solo e dimenticato da tutti, proprio come il bambino di Colette, di Ravel, di Sendak, proprio come Cenerentola isolata, stanca e sporca di cenere, eppure ha ritrovato la via verso gli altri, verso la crescita e la gioia. Se qualcuno che è colpevole come lui si è liberato dall'angoscia, anche a lui può accadere. L'infanzia è il tempo della speranza, e la stessa vita adulta, che comincia accettando la perdita di tante illusioni, ha nella speranza la sola risorsa che può aiutare a uscire dalle situazioni più gravi. La tragedia comincia dove la speranza scompare. La speranza è alimentata dalla compassione che trasforma le presenze persecutorie del bosco in figure soccorrevoli, e la solitudine buia finisce: in questa storia che è una musica e una danza si accende prima una lampada, poi la luna, poi viene il giorno.
Dalle
finestre,
si vede una luce accendersi nella casa. Nello
stesso momento, la luna, svelata, e l’alba color
rosa e oro inondano il giardino di un chiarore
puro. Canto di usignoli, mormorii di alberi e di
animali. Gli
animali, uno dopo l’altro, si ritirano,
togliendo piano, piano al bambino il loro
sostegno, ormai divenuto inutile, e disfano
armoniosamente ma con dispiacere il gruppo che
gli avevano formato attorno, continuando a
scortarlo da un po’ più lontano. Lo
festeggiano con battiti d’ali e con capriole di
gioia, poi sciolgono il loro amichevole corteo
all’ombra degli alberi, lasciando il bambino da
solo. Dritto, luminoso e biondo, nella luce
della luna all’alba, il bambino tende le braccia
verso la persona che gli animali hanno chiamato:
“Mamma!”
(Colette, cit.) [1] Storia del pescatore e del demone, in Le mille e una notte, cit., vol. I, pp. 21 sgg. [2] Un video del balletto di Ravel, su testo di Colette, nella coreografia di Jiri Kylian, Orchestra national de Paris diretta da Lorin Maazel (1986), è accessibile on-line: I parte, http://www.youtube.com/watch?v=MFViB9vrB1E; II parte, http://www.youtube.com/watch?v=mX0WKrrMkDE; III parte, http://www.youtube.com/watch?v=c2BCyDlUKMk; IV parte, http://www.youtube.com/watch?v=YFQ5Otz8SEI; V parte, http://www.youtube.com/watch?v=ozIf-d8WarY, consultato il 10 febbraio 2009. [3] Si tratta dell’intersezione fra arte e psicoanalisi, che mostra una particolare fecondità, già riconoscibile negli scritti sull’arte di Freud. [4] Si ricordi un particolare del film di Kim Ki-duk Primavera, Estate, Autunno, Inverno …e ancora Primavera (Corea del Sud, 2003). Il piccolo protagonista ha lasciato morire un piccolo rettile, e questa sua mancanza di pietà lo porterà alle sue tragiche esperienze di vita. Solo dopo aver compreso l’insegnamento del suo maestro potrà ritrovare pace, e prenderne il posto, accogliendo un bambino abbandonato, come il monaco aveva accolto lui, per una nuova primavera. |